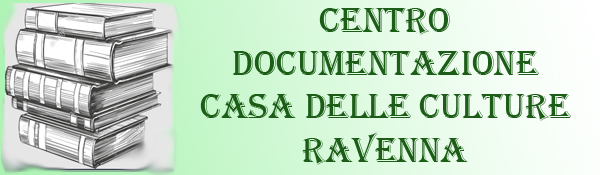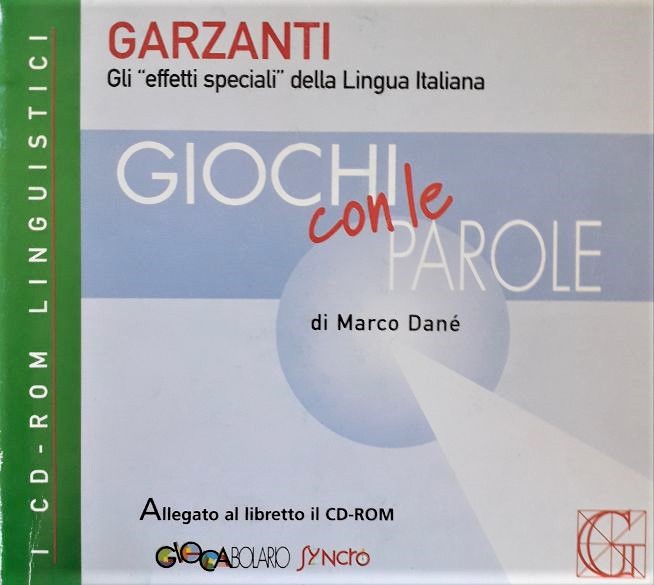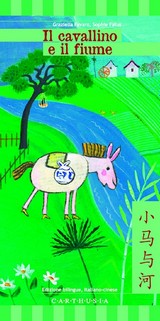Per richiedere un prestito è necessario registrarsi
Aldo Palazzeschi

Aldo Pietro Vincenzo Giurlani nasce a Firenze nel 1885; all'età di diciassette anni si iscrive ad una scuola di recitazione teatrale e per non indispettire il padre, contrario alla carriera teatrale, decide di adottare il cognome della nonna, Palazzeschi, come nome d'arte che lo accompagnerà per il resto della vita.
Alla passione per il teatro si sostituisce rapidamente quella per la poesia, e così nel 1905 dà alle stampe I cavalli bianchi, una raccolta di liriche in stile crepuscolare, che gli fa ricevere i complimenti di Sergio Corazzini.
Seguono anni di sperimentazione che si concretizzano nella pubblicazione di diverse raccolte liriche e del suo primo romanzo dal titolo “:riflessi”; la composizione poetica è imperniata sull'uso del metro ternario (tre sillabe metriche) e che, fatti salvi alcuni debiti nei confronti di Pascoli, D'Annunzio e Govoni, presenta diversi e forti elementi di originalità, caratteristiche che emergono nella più riuscita delle raccolte di questo periodo: Poemi (1909).
Una svolta importante si ha con l'avvicinamento al movimento futurista, l'avanguardia letteraria che più di tutte ha segnato in modo profondo il primo Novecento. Marinetti, autore del Manifesto del Futurismo, colpito dalle liriche contenute in Poemi, elogia Palazzeschi e gli propone di collaborare alla sua rivista.
Inizia il periodo più significativo della produzione del fiorentino: nel 1910 pubblica Incendiario, una raccolta poetica futurista, mentre l'anno successivo dà alle stampe Il codice di Perelà, romanzo considerato la migliore opera in prosa del futurismo italiano.
Ma la rottura insanabile con quest'ambiente avviene quando Palazzeschi si dichiara contrario all'entrata dell'Italia nel conflitto della Prima Guerra Mondiale, cosa che lo pone in forte contrasto con il resto del gruppo, decisamente interventista. Nel 1920, scrive Due imperi...mancati, sorta di diario cui affida amare riflessioni sul disastroso conflitto che si era appena concluso e sui danni del militarismo, che viene condannato fermamente; ritornerà sull’argomento con Tre imperi…mancati (1945) in cui approfondisce le sue riflessioni alla luce della disastrosa guerra appena conclusa.
Durante il Ventennio si tiene lontano dalla cultura del regime ma continua la sua attività letteraria e collabora con il Corriere della Sera.
Nel 1934 pubblica Le sorelle Materassi, una particolare storia famigliare incentrata sulla solitudine delle quattro protagoniste che viene accolta con particolare favore dalla critica. Questo romanzo segna l'abbandono dello sperimentalismo e l’adesione ad uno stile narrativo più tradizionale, improntato sull’ironica descrizione dei costumi e dei modi della piccola borghesia.
Sul finire degli anni '60 le neoavanguardie letterarie riscoprono l'opera del primo Palazzeschi, e lo stesso autore, seppure con distacco, si lascia coinvolgere da queste nuove correnti e scrive tre nuovi romanzi - Il Doge (1967), Stefanino (1969) e Storia di un'amicizia (1971) – e due raccolte poetiche – Cuor mio (1968) e Via delle cento stelle (1972) – segnando il suo ritorno allo sperimentalismo letterario.
Si era trasferito a Roma nel 1940, dove si spegne nel 1974.