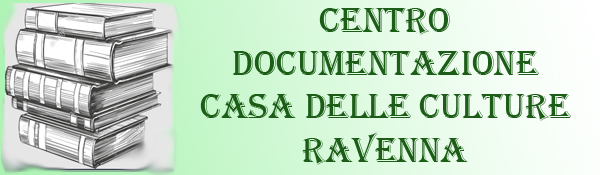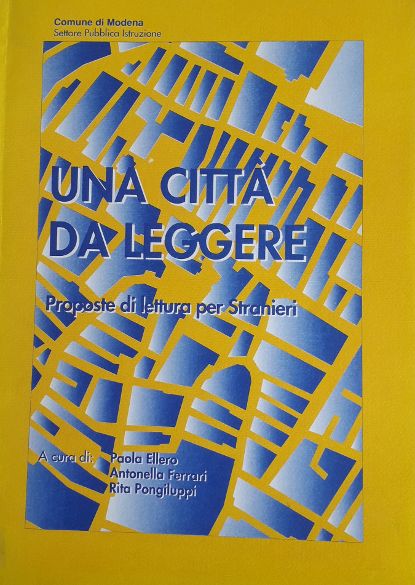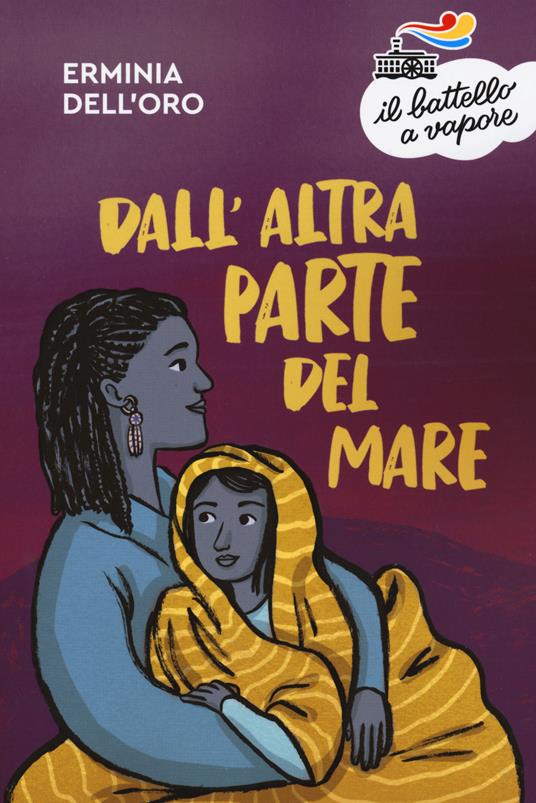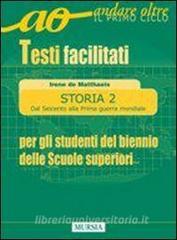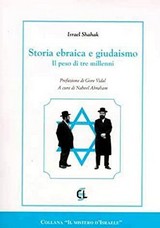Storico e geografo dei Paesi stranieri
La Historia austrialis fu composta in tre redazioni, le prime due delle quali, scritte tra il 1453 e il 1455, appartengono all’ultimo periodo che Piccolomini trascorse nell’impero prima di tornare definitivamente in Italia nel maggio 1455. Insieme al Dialogorum libellus essa chiude quindi il suo periodo letterario a Nord delle Alpi. Soprattutto con la seconda redazione della Historia austrialis (1454-1455), Piccolomini creò il modello umanistico di un’opera storica incentrata su un territorio nazionale e il suo popolo (Landesgeschichte). L’opera si apre con un’epistola dedicatoria all’imperatore Federico III; seguono un’introduzione con la discussione del nome e della topografia dell’Austria, una descrizione della città di Vienna e la presentazione della ‘preistoria’ dell’Austria. Specialmente nella descrizione di Vienna, Piccolomini si mostra un osservatore appassionato delle particolarità etnologiche del popolo. Nella terza redazione, stesa dopo il ritorno in Italia, ma prima che Piccolomini diventasse papa (cioè nel periodo tra il 1455 e il 1458), egli aggiunge un grande excursus sulla storia della casa degli Hohenstaufen.
L’opera corrisponde ai criteri della storiografia umanistica sia nel suo stile sia nelle sue intenzioni. Piccolomini attinge allo stile degli storici antichi romani (come Sallustio e Cesare), senza tuttavia aderire troppo strettamente a un solo modello. Per quanto riguarda l’uso delle fonti, egli dimostra senso critico filologico e anche un certo scetticismo verso le leggende. Si distanzia, inoltre, dall’idea medievale di storia della salvezza dell’uomo (cfr. l’introduzione di Martin Wagendorfer alla Historia austrialis, hrsg. J. Knödler, M. Wagendorfer, 2009, pp. XXIII-XXIV).
Per la ‘preistoria’ dell’Austria, usa e critica severamente una cronaca del 14° sec., composta da un autore ignoto (la Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften), per la cui traduzione dal tedesco ricevette l’aiuto di Johannes Hinderbach, l’amico consigliere dell’imperatore che più tardi diventò vescovo di Trento (cfr. l’introduzione di Wagendorfer, cit., pp. XXXVII-XXXVIII; per le critiche, Historia austrialis, cit., p. 287: «storia […] assurda e falsa»). Per l’excursus sulla storia degli Hohenstaufen fino alla loro estinzione nel 1268 (Historia austrialis, cit., pp. 336-426), Piccolomini usò fonti come i Gesta Friderici e la Chronica di Ottone di Frisinga (m. 1158) e, per il periodo successivo, le Decades di Biondo Flavio. Sembra, tra l’altro, che Piccolomini abbia giocato un ruolo decisivo nella riscoperta di Ottone di Frisinga, cronista medievale di rilievo che era caduto in oblio.
Si ipotizza che la parte, molto dettagliata, relativa alla storia degli Hohenstaufen, venisse inclusa nella terza redazione, scritta durante il cardinalato, perché Piccolomini voleva mostrare all’imperatore come la collaborazione tra papi e imperatori, già sperimentata in passato, potesse fornire un modello per la nuova crociata contro i turchi. Piccolomini selezionava attentamente le informazioni offerte nelle fonti, soprattutto da Ottone di Frisinga, per mettere in rilievo l’operato di Federico Barbarossa e di re Corrado III a favore delle crociate, mentre le informazioni più scomode, relative ai contrasti tra i papi e gli imperatori, vennero tralasciate (cfr. Wagendorfer 2003, pp. 101-42). Per gli eventi connessi a Federico III sino all’anno 1455, Piccolomini si servì dei documenti del carteggio ufficiale della cancelleria dell’imperatore, nella quale egli lavorava (cfr. l’introduzione di Wagendorfer, cit., p. LII).
Possiamo valutare Piccolomini, per quanto riguarda questo testo, come un informatore ambivalente – a volte affidabile, altre meno. Commette errori quando descrive eventi sulla base del ricordo personale; inoltre altera la prospettiva di alcune fonti, per convincere i lettori dei suoi argomenti (cfr. l’introduzione di Wagendorfer, cit., pp. XXVII-XXX).
La Historia austrialis, a causa della sua tarda pubblicazione a stampa (1685), nel Quattro e nel Cinquecento fu recepita in misura minore rispetto a un’altra Landesgeschichte, la Historia bohemica. Nonostante ciò, nella Historia austrialis Piccolomini aveva coniato il modello umanistico per la stesura delle storie nazionali. In seguito, i suoi principi sarebbero stati imitati da molti altri scrittori (cfr. l’introduzione di Wagendorfer, cit., p. CLXXI). Sono particolarmente notevoli, innovativi e influenti sia il fatto che scrivesse da straniero la storia di un altro Paese, sia il modo in cui univa metodicamente la descrizione geografica, etnografica e culturale con la materia storica.
Piccolomini si era interessato alla Boemia già in precedenza, in particolare quando il Concilio di Basilea aveva affrontato il problema degli Hussiti. Nel 1451 fu inviato in missione diplomatica in Boemia come membro della delegazione imperiale e l’anno seguente vi fu nominato legato apostolico da papa Niccolò V. Queste esperienze gli permisero di scrivere la Historia bohemica in poche settimane, durante un soggiorno termale a Viterbo nell’estate del 1458. Rispetto alla precedente Historia austrialis, quest’opera è più omogenea e organica, più centrata sull’argomento e stringente nella struttura e nel contenuto.
Qui emerge meno la figura dell’autore, così come minori sono le curiosità aneddotiche su quei personaggi che avevano un ruolo minore nella storia del Paese (mentre nella Historia austrialis Piccolomini si era soffermato, per es., sulle amanti di Francesco Sforza e del re Alfonso di Aragona: cfr. Montecalvo, in Pius II, 2003, p. 79). Nel complesso la Historia bohemica è stata considerata «il capolavoro storiografico della carriera pre-papale di Piccolomini» (Montecalvo, in Pius II, 2003, p. 81). Quest’opera fu anche il suo scritto di storia maggiormente diffuso, tanto da veicolare un’immagine della Boemia destinata a restare famosa per secoli in tutto il mondo cristiano (cfr. Špička 2007).
L’opera, dedicata al re Alfonso V d’Aragona, si apre con una descrizione geografica del Paese. Seguono sia un tentativo di descrivere le origini della nazione boema, sia la presentazione della storia medievale del Paese fino agli anni a lui contemporanei. Il nucleo più importante della Historia si concentra sul movimento riformatore e rivoluzionario degli Hussiti, del quale Piccolomini spiega la diffusione, denunciandolo però come eretico. Egli giudica le tradizioni sui miti di fondazione e l’origo gentis poco utili per ricostruire la storia, soprattutto quella più remota, di un popolo. Non a caso, critica l’atteggiamento di quanti, per dar loro prestigio, ricercavano le origini di un popolo in un passato mitico. Riguardo ai Boemi, in particolare, ironizza sul fatto che si proclamassero discendenti dagli Sclavi, cioè da uno dei popoli che avevano costruito la Torre di Babele:
Quelli che vogliono imitare i Boemi, cercando la nobiltà di origine nella antichità stessa, rivendicheranno facilmente i loro inizi non più dalla torre di Babele, ma addirittura dall’arca di Noè, e perfino dal paradiso delle delizie e dai primi genitori e dall’utero di Eva, da dove tutti sono usciti. Noi tralasciamo queste cose come vecchie fandonie (Historia bohemica, a cura di D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl, 1998, pp. 13-14; cfr. Montecalvo, in Pius II, 2003, p. 69).
La storia nazionale, secondo Piccolomini, non doveva partire dalla creazione del mondo, come accadeva nelle cronache medievali, ma doveva essere narrata dal momento in cui una regione aveva iniziato a essere abitata dal gruppo etnico che vi sarebbe poi rimasto ininterrottamente (Montecalvo, in Pius II, 2003, p. 70). Lo spirito critico di Piccolomini fu, però, meno sistematico di alcuni suoi contemporanei, quale, per es., Biondo Flavio, rispetto al quale ebbe probabilmente minor tempo e pazienza per confrontare e collazionare le fonti. Il metodo di Piccolomini nella critica delle fonti si basava, piuttosto, sul criterio della verosimiglianza. Per es., egli trovò poco credibile, come invece affermato in alcune fonti, che nella Boemia antica sia donne sia uomini andassero in giro nudi: il clima freddo, egli commentava, semplicemente non lo avrebbe permesso (Historia bohemica, cit., p. 16; cfr. Montecalvo, in Pius II, 2003, p. 60).
L’occasione per la stesura della Germania (scritta fra il 1457 e il 1458) fu una lettera inviatagli nel 1457 da Martin Mayr, cancelliere dell’arcivescovo di Magonza. Tramite essa (che Piccolomini ci tramanda in versione probabilmente abbreviata e revisionata da lui stesso), Mayr presentava le lamentele del vescovo circa i rapporti tra la Santa sede e la Germania, che erano arrivate dall’arcivescovo di Magonza:
È noto che si respingono ad occhi chiusi le elezioni dei prelati e si riservano benefici e dignità d’ogni genere ai cardinali ed ai protonotari; e in verità tu stesso hai ottenuto la riserva su tre provincie tedesche […] Si concedono spettative senza numero; si riscuotono le annate – ossia la metà delle rendite – senza alcuna dilazione […] Si dà l’amministrazione delle chiese non a chi più merita, ma a chi più offre. Per raccogliere denaro, si promulgano ogni giorno nuove indulgenze, e, col pretesto dei Turchi, si ordina la riscossione delle decime senza aver prima consultato i nostri prelati (Germania, a cura di M.G. Fadiga, 2009, pp. 135-36; trad. it. di G. Paparelli, 1949, pp. 17-19).
La risposta di Piccolomini consistette in un ritratto della Germania, in cui essa era descritta come ricca e capace di accettare tali interventi e pagare le somme in discussione. Lo scritto era solo in parte rivolto ai tedeschi; in verità, Piccolomini intendeva rendere evidenti le sue capacità diplomatiche anche agli occhi dei suoi colleghi nel collegio cardinalizio. D’altro canto, è un fatto che lo stesso Piccolomini, da poco nominato cardinale, per aumentare le sue entrate volesse ottenere delle prebende in Germania e, in vista di ciò, cercasse di giustificare tale concessione. Tralasciamo qui le motivazioni politiche e personali, per sottolineare che la Germania fu in ogni caso la prima descrizione completa del Paese redatta in età moderna, ponendo i fondamenti sia della storiografia nazionale tedesca sia del patriottismo tedesco; Piccolomini è stato perfino ritenuto il padre della coscienza nazionale tedesca, come unità politica e culturale, nel Quattro e Cinquecento. La lunga esperienza di più di vent’anni passati in Germania non solo gli conferì le conoscenze necessarie per descrivere il Paese, ma lo rese un tramite tra i tedeschi e il mondo italiano. Di fatto, Piccolomini, nella seconda metà del Quattrocento, fu l’autore di maggior successo sul mercato librario in Germania. Era ben più noto degli stessi autori tedeschi e può essere considerato «l’apostolo dell’umanesimo» a Nord della Alpi (cfr. Voigt 1856-1863, 2° vol., pp. 342-58; Worstbrock 19892, coll. 660-61).
Nel procedere nella sua descrizione dei territori d’Oltralpe, Piccolomini paragona due diversi momenti storici: la Germania barbarica dell’antichità e quella cristiana del presente, nella quale la nazione splende per potere e ricchezza sia materiale sia culturale. Unico suo punto debole, scrive Piccolomini, era che essa fosse frammentata in molti potentati locali che, refrattari all’unità politica, non sostenevano l’imperatore (Germania, cit., liber II, p. 216). Nella sezione dedicata ai costumi e alla cultura, Piccolomini loda la Germania per le sue università e l’ospitalità dei suoi abitanti. A suo avviso, solo un elemento barbarico è rimasto: la lingua tedesca (p. 212).
Per il resto erano stati i Romani antichi e la Chiesa cattolica ad aver civilizzato i tedeschi. La Chiesa, in particolare, aveva reso «cristiani gli infedeli, latini i barbari, onesti i viziosi, e aveva salvato i dannati» (Germania, cit., liber III, p. 240). La conquista romana, invece, aveva persino permesso ai Germani di entrare nella storia, dato che senza le descrizioni della Germania fornite dagli storici greci e romani non vi sarebbe neppure stata memoria di quell’antico popolo.
Le fonti per la Germania antica usate da Piccolomini furono il Bellum Gallicum di Cesare, la Geografia di Strabone e la Germania di Tacito (cfr. l’introduzione di Maria Giovanna Fadiga all’edizione della Germania, cit., pp. 53-57), auctoritates quindi della storiografica classica, molto più attendibili delle leggende medievali e delle genealogie fittizie che spesso si usavano per narrare la ‘preistoria’ di un popolo. Da notare che, alla metà del Quattrocento, il testo di Tacito era ancora pressoché sconosciuto. Piccolomini potrebbe essere stato uno dei primi a vedere l’unico manoscritto che ne ha trasmesso il testo, scoperto alcuni anni prima in un monastero tedesco e portato a Roma da Enoch d’Ascoli nel 1455. Né si può escludere che Piccolomini avesse colto il recente ritrovamento come occasione e punto di partenza per redigere il suo testo, del quale lo stesso titolo Germania è apertamente mimetico.
Piccolomini compose poi altre due opere di carattere prevalentemente geografico: il De Europa nel 1458 e il De Asia nel 1461. Ambedue dovevano fare parte probabilmente di una descrizione del mondo (Cosmographia) rimasta incompiuta per la morte dell’autore. Entrambi gli scritti si basano su autori antichi come Strabone, Tolomeo e Plinio il Vecchio. Mentre, però, la descrizione dell’Europa tiene conto anche del continente nella sua realtà contemporanea all’autore (prendendo, tra l’altro, metodicamente spunto dall’Italia illustrata di Biondo Flavio), quella dell’Asia fornisce non molto più di una summa del sapere antico.
L’Asia e anche alcune pagine dell’Europa vennero composte con intento chiaramente polemico: Piccolomini sostiene che gli antenati dei turchi erano violenti, crudeli e spregevoli, fatto che doveva aiutarlo, da papa, a organizzare la sua crociata contro gli stessi turchi. Secondo uno studio recente, per sostanziare questo suo orientamento polemico, Piccolomini avrebbe accuratamente selezionato i passi delle fonti in cui gli Sciti, ritenuti antenati dei turchi, erano presentati in modo negativo, ignorando invece altri brani di segno opposto; uguale atteggiamento avrebbe usato riguardo alle fonti medievali, alcune delle quali (come la cosmografia di Aethicus Ister) di tipo fantastico (cfr. Meserve, in Pius II, 2003). Una connotazione antiottomana era presente anche nell’Europa, che a tal proposito si poneva un obiettivo ideale di non poco conto: descrivere (o piuttosto poter descrivere) una comunità di cristiani, uniti nella religione e nella cultura contro la minaccia turca.
L’autobiografia come panorama storico
Fra le opere di Piccolomini i Commentarii (1462-1464) rappresentano una vera e propria autobiografia, che dalla giovinezza si estende sino agli anni del pontificato. I Commentarii sono uno dei testi più importanti della letteratura umanistica e costituiscono una fonte di straordinario interesse per la storia italiana ed europea della metà del Quattrocento. Piccolomini vi ripercorre la propria vita, giustificando le sue azioni e fissando un’immagine virtuosa di sé sia come politico, sia come pontefice. L’argomento principale dei Commentarii è, ancora una volta, la preparazione della spedizione contro i turchi. In ciò si ha un interessante punto di contatto con i Commentarii de bello Gallico di Giulio Cesare: anche questi voleva giustificare, con il suo scritto, una spedizione militare e, allo stesso tempo, esaltare la propria figura.
Un altro modello comportamentale è poi rappresentato, per Piccolomini, da Enea: come l’eroe cantato da Virgilio, anche Piccolomini per raggiungere il proprio obiettivo, ossia convincere gli alleati della necessità della crociata, si descrive come costretto a viaggiare di continuo (cfr. Enenkel 2008, pp. 300-29; O’Brien 2009). Così come Piccolomini varia, in modo agile e quasi giocoso, le allusioni al generale Cesare e all’eroe mitico Enea, allo stesso modo riformula e cambia anche le fonti documentarie e storiche che usava per narrare la sua autobiografia. Infatti, Piccolomini era famoso per la grande variatio che usava nelle sue orazioni, così che anche se parlava spesso degli stessi temi usava raramente le stesse parole. In modo simile, nei suoi testi scritti modificava le fonti a sua disposizione a tal punto che ancora oggi con un semplice confronto dei testi diventa quasi impossibile trovare l’originale (cfr. Märtl 2006, p. 248).
Il valore dei Commentarii come documento per la storia degli anni centrali del Quattrocento è evidente, in quanto il loro autore fu testimone oculare o, addirittura, fu coinvolto direttamente negli eventi narrati. È meno evidente invece il loro valore come scritto storico contenente molti excursus sul passato più remoto – questo anche a causa dell’impossibilità di individuare le fonti di tali excursus (come sopra accennato). Per quest’aspetto, che resta da studiare sulla base delle recenti edizioni critiche, basti un esempio. Nel terzo libro dei Commentarii (capp. 26-30; a cura di L. Totaro, 1° vol., 1984, pp. 530-69) si parla della storia di Venezia. Per redigere questa parte Piccolomini si basava su alcuni estratti presi dalle opere di Biondo Flavio e raccolti in un manoscritto che è ancora conservato. Da una lettura dei Commentarii, si possono dunque osservare le modifiche che caratterizzano il modo di lavorare di Piccolomini. Come prima cosa egli trasforma lo stile di Biondo, rendendolo maggiormente aderente al suo. Poi, in contrasto con Biondo (che era personalmente più legato a Venezia), mette in dubbio i miti dello Stato veneziano. Invece di godere di una piena libertas, i veneziani sarebbero stati soggetti all’impero bizantino e poi avrebbero ricevuto privilegi decisivi dal papa senese Alessandro III (1159-81); e anche all’interno dello Stato non vi erano libertà e uguaglianza, ma vigeva un’oligarchia tirannica. Di conseguenza, e anche perché erano ricchissimi, i veneziani erano obbligati, secondo Piccolomini, a partecipare alla crociata contro i turchi (cfr. Märtl 2006, pp. 242-44).
I Commentarii, quindi, sono un’opera affascinante per le variazioni di prospettiva. Piccolomini passa dal resoconto di fatti a lui contemporanei agli excursus storici, a cui aggiunge descrizioni di città e paesaggi, valutazioni di personaggi e aneddoti personali di straordinaria vivacità. Furono editi a stampa per la prima volta, in versione censurata, nel 1584 (cfr. Honegger Chiari 1991) e bisognò aspettare il 1984 per leggerli in versione critica e completa. Rimangono a tutt’oggi la sola autobiografia di un papa stesa in età umanistica, nonché un monumento unico della libertà di espressione del primo Rinascimento. Il testo può essere ritenuto «l’opera storica più moderna e spregiudicata prodotta dalla cultura italiana del ’400» (Prosperi 2006, p. 374).
Opere
De gestis concilii Basiliensis commentariorum libri II (1439-1440), ed. D. Hay, W.K. Smith, Oxford 1967, 19922.
De viris illustribus (1440-1450 ca.), edidit A. van Heck, Città del Vaticano 1991.
De rebus Basileae vel stante vel dissoluto concilio gestis commentariolum (1450-1451), hrsg. R. Wolkan, in Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. R. Wolkan, 2° vol., Wien 1912, pp. 164-228.
Dialogus (1453-1455), hrsg. D.R. Henderson, Hannover 2011 (trad. it. precedente di A. Scafi, Dialogo su un sogno, Torino 2004).
Historia austrialis (1453-1458), hrsg. J. Knödler, M. Wagendorfer, Hannover 2009.
Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini (ed. delle lettere fino al 1454), hrsg. R. Wolkan, 3 voll., Wien 1909-1918.
Germania (1457-1458), a cura di M.G. Fadiga, Firenze 2009 (trad. it. precedente parziale, solo del libro II, di G. Paparelli, Firenze 1949).
De Europa (1458), edidit A. van Heck, Città del Vaticano 2001.
Historia bohemica (1458), a cura di D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl, Praha 1998.
Descripción de Asia (1461), a cura di D.F. Sanz, Madrid 2010.
In minoribus agentes (bolla di ritrattazione, 26 aprile 1463), in Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, 5° vol., a cura di F. Gaude, Augustae Taurinorum 1860, pp. 173-80.
Per i Commentarii (1462-1464) si vedano le edizioni:
Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, edidit A. van Heck, 2 voll., Città del Vaticano 1984.
I Commentarii, a cura di L. Totaro, 2 voll., Milano 1984, 20042 (con traduzione italiana).
Commentarii, recensuerunt I. Bellus, I. Boronkai, 2 voll., Budapest 1993-1994.